Sileno di Calatte
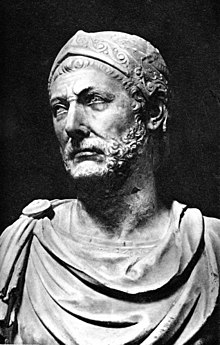
Sileno (Calatte, metà III secolo a.C. – dopo il 202 a.C.) è stato uno storico greco antico.
Biografia e opere[modifica | modifica wikitesto]
Oriundo di Calatte, delle opere di Sileno non restano che 9 frammenti[1].
Era soprattutto noto nell'antichità per aver scritto una storia fortemente retorica della guerra annibalica, seguendo il condottiero cartaginese insieme al collega storiografo Sosilo[2], anche se Cicerone[3] afferma diligentissime res Hannibalis persecutus est. Sempre nello stesso passo Cicerone, parafrasando un passo di Sileno, evidenzia come questa storia fosse fortemente influenzata dall'aspetto "drammatico"[4]:
«Un altro episodio è riferito nella storia, scritta in greco, di Sileno, da cui lo attinse Celio (Sileno narrò con grande accuratezza le imprese di Annibale). Dopo la presa di Sagunto, Annibale sognò che era chiamato da Giove nel concilio degli dèi. Giunto là, si sentì ordinare da Giove di portar guerra all'Italia, e gli venne dato come guida un dio del concilio. Seguendo le indicazioni di costui, incominciò a mettersi in marcia con l'esercito. Quel dio, allora, gli ordinò di non voltarsi a guardare indietro. Ma Annibale non riuscì a resistere a lungo, e, cedendo alla bramosia di vedere, si voltò. Vide una belva enorme e orrenda, cinta da serpenti, la quale, dove passava, abbatteva ogni albero, ogni virgulto, ogni casa. Annibale, stupefatto, chiese al dio che lo guidava che cos'era mai un mostro di quella sorta; e il dio rispose che quella era la devastazione dell'Italia e gli ordinò di continuare il cammino, senza curarsi di ciò che avveniva dietro, alle sue spalle.»
Non è chiaro, però, se la sua trattazione avesse o meno un’impostazione marcatamente propagandistica. Di certo Sileno non si limitava a riferire contenuti di carattere politico-militare, ma, come evidente anche dal frammento riportato, dava peso anche a sogni e mirabilia[5]. L'opera su Annibale fu utilizzata, tra gli altri, da Celio Antipatro[6] e da Livio per la sua seconda deca[7], poiché si trattava, secondo alcuni studiosi, di «un resoconto storico neutrale (vedi F 2; ma anche a F6). Ciò è comprensibile se aveva scritto solo quando il fallimento di Annibale era chiaro (F 2)»[8].
Secondo la maggior parte degli studiosi[9], invece, si trattava di un'opera spiccatamente propagandistica, come sarebbe possibile rilevare da una circostanziata allusione di Polibio[10]:
«Alcuni degli scrittori che hanno descritto questo passaggio delle Alpi, per voler impressionare i loro lettori con le meraviglie che raccontano di queste montagne, sono traditi in due vizi sempre più estranei alla vera storia; poiché sono costretti a fare sia affermazioni false che affermazioni che si contraddicono a vicenda. Mentre da un lato presentano Annibale come un condottiero di ineguagliabile coraggio e lungimiranza, ce lo presentano incontestabilmente come del tutto privo di prudenza, e ancora, non potendo portare a termine la loro serie di falsità o portare a termine, introducono dèi e i figli degli dei nella sobria storia dei fatti. Rappresentando le Alpi così ripide e aspre che non solo i cavalli e le truppe accompagnate da elefanti, ma anche uomini attivi a piedi avrebbero difficoltà a passare, e allo stesso tempo raffigurandoci la desolazione del paese come tale, che, se qualche dio o eroe non avesse incontrato Annibale e gli avesse mostrato la via, tutto il suo esercito si sarebbe smarrito e sarebbe morto del tutto, senza dubbio ricadono in entrambi i vizi di cui sopra.»
Sappiamo, inoltre, da Ateneo, di una Storia della Sicilia in almeno 3 libri[11], in cui, tra l'altro, si occupava di culti anche dal punto di vista mitografico[12]: secondo alcuni[13], anzi, avrebbe potuto benissimo essere un'opera paradossografica di tipo periegetico che trattava delle meraviglie della Sicilia piuttosto che una storia su larga scala dell'Occidente [14].
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Raccolti in FGrHist 175.
- ^ Cornelio Nepote, Anibale, 13.
- ^ De divinatione, I, 49.
- ^ FGrHist 175 F 3.
- ^ Ad esempio, il riferimento ad una fonte nel tempio di Eracle a Gades, la cui acqua si abbassava con l'alta marea e si alzava con quella bassa, in F 9 (= Strabone III 5, 7).
- ^ O. Skutch, The Annals of Q. Ennius, Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 450.
- ^ Viene citato in XXVI 49, 3 (= FGrHist 175 F 6).
- ^ F. Jacoby, Introduzione alle testimonianze e ai frammenti di Sileno (FGrHist 175). Per un'ostilità di Sileno nei confronti di Roma si pronuncia R. Lauritano, Sileno in Diodoro, in «Kokalos», 2 (1956), pp. 206-216.
- ^ Si veda, ad esempio, K. Meister, Annibale in Sileno, in «Maia» XXIII 1971, pp. 3-9.
- ^ III 47, 6-9.
- ^ XII, 542A.
- ^ Si veda la genealogia dei Palici in F 7.
- ^ F. W. Walbank, A historical Commentary on Polybius, vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 496-497.
- ^ Cfr. F 3-5.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- R. Lauritano, Sileno in Diodoro, in «Kokalos», 2 (1956), pp. 206-216.
- K. Meister, Annibale in Sileno, in «Maia» XXIII (1971), pp. 3-9.
- D. Briquel, Sur un fragment de Silènos de Kalè Actè (le songe d'Hannibal, FGrHist 175, F 8): à propos d'un article récent, in «Ktèma», 2004, pp. 145-157.
- I. Concordia, Storiografia siceliota frammentaria, Vol. 5. Da Sileno di Calatte a Polo di Agrigento. Testimonianze e frammenti, s.l., Youcanprint, 2016 - ISBN 8892622781
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 54537368 · CERL cnp00285800 · GND (DE) 102405964 · WorldCat Identities (EN) viaf-54537368 |
|---|