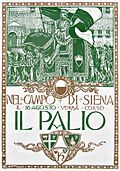Palio di Siena: differenze tra le versioni
→Chi corre: +data |
|||
| Riga 276: | Riga 276: | ||
*alcol-test ai fantini<ref>[http://www.style.it/news/le-notizie-del-giorno/2010/07/02/palio-di-siena--alcol-test-per-i-fantini.aspx Palio di Siena, alcol-test per i fantini - Style.it<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> come da ordinanza del sottosegretario alla Salute [[Francesca Martini]]<ref>[http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=30010 ORDINANZA del 21 luglio 2009<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>. |
*alcol-test ai fantini<ref>[http://www.style.it/news/le-notizie-del-giorno/2010/07/02/palio-di-siena--alcol-test-per-i-fantini.aspx Palio di Siena, alcol-test per i fantini - Style.it<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> come da ordinanza del sottosegretario alla Salute [[Francesca Martini]]<ref>[http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=30010 ORDINANZA del 21 luglio 2009<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>. |
||
Tali misure vengono giudicate comunque insufficienti da alcune associazioni animaliste, che continuano a chiedere l'abolizione della gara. Proprio al riguardo, uno studio del [[2010]] condotto dall'[[Università di Parma]]<ref>{{cita pubblicazione | autore=Zanichelli Stefano|coautori = Botti Benedetta, Lipreri Giulia| titolo=Le patologie traumatiche del cavallo-atleta: corse regolari e Palii a confronto|anno=2010| mese=aprile| pagine=1-13|url=http://www.sunto.biz/2010/08/26/Relazione%20Zanichelli.pdf}}</ref> finalizzato alla comparazione delle patologie traumatiche dei cavalli da ippodromo e da corse storiche degli ultimi venti anni, ha permesso di verificare che non esiste differenza in termini percentuali tra incidenti nelle corse regolari e nelle corse storiche<ref>Come indicato nello studio, per "corse regolari" si intendono le manifestazioni organizzate da associazioni riconosciute quali ad esempio: [[Unione Nazionale Incremento Razze Equine|UNIRE]], [[Federazione Italiana Sport Equestri|FISE]], [[Fédération Équestre Internationale|FEI]]. Per corse |
Tali misure vengono giudicate comunque insufficienti da alcune associazioni animaliste, che continuano a chiedere l'abolizione della gara. Proprio al riguardo, uno studio del [[2010]] condotto dall'[[Università di Parma]]<ref>{{cita pubblicazione | autore=Zanichelli Stefano|coautori = Botti Benedetta, Lipreri Giulia| titolo=Le patologie traumatiche del cavallo-atleta: corse regolari e Palii a confronto|anno=2010| mese=aprile| pagine=1-13|url=http://www.sunto.biz/2010/08/26/Relazione%20Zanichelli.pdf}}</ref> finalizzato alla comparazione delle patologie traumatiche dei cavalli da ippodromo e da corse storiche degli ultimi venti anni, ha permesso di verificare che non esiste differenza in termini percentuali tra incidenti nelle corse regolari e nelle corse storiche<ref>Come indicato nello studio, per "corse regolari" si intendono le manifestazioni organizzate da associazioni riconosciute quali ad esempio: [[Unione Nazionale Incremento Razze Equine|UNIRE]], [[Federazione Italiana Sport Equestri|FISE]], [[Fédération Équestre Internationale|FEI]]. Per "corse storiche" si intendono quelle che restano al di fuori di tali circuiti.</ref>. In particolar modo, un'analisi approfondita degli ultimi quarant'anni del Palio di Siena ha permesso di scoprire che vi è stata una riduzione percentuale di incidenti catastrofici: dal 2,20% di incidenti nel decennio 1970-79 allo 0,53% del decennio 2000-09<ref>{{cita web|url=http://www.sunto.biz/2010/08/26/Relazione%20Zanichelli.pdf|titolo=Le patologie traumatiche del cavallo-atleta: corse regolari e Palii a confronto|editore=[[Università di Parma]]|accesso=14-10-2010|formato=Pdf}}</ref>. |
||
== Terminologia == |
== Terminologia == |
||
Versione delle 01:14, 22 giu 2013
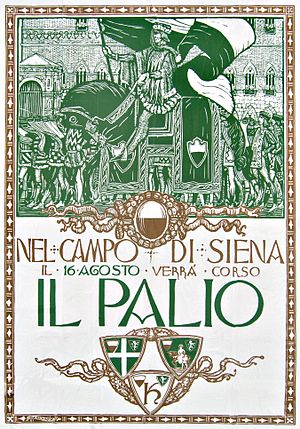
Il Palio di Siena è una competizione fra le contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale.
La "Carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio di Luglio (in onore della Madonna di Provenzano) e il 16 agosto il Palio di Mezzo Agosto corso in origine il 15 agosto (in onore della Madonna Assunta).
In occasione di avvenimenti eccezionali (come ad esempio nel 1969 la conquista della Luna da parte della missione Apollo 11) o di ricorrenze cittadine o nazionali ritenute rilevanti e pertinenti (ad es. il centenario dell'Unità d'Italia) la comunità senese può decidere di effettuare un Palio straordinario, tra maggio e settembre (l'ultimo si è tenuto nel 2000, per celebrare l'ingresso nel nuovo millennio).
Contrade
La storia del Palio
Secondo alcune fonti, fu probabilmente in ricordo della memorabile battaglia di Montaperti (1260) e dello scampato pericolo che i senesi decisero di indire il famoso Palio,[2] ritenuto da molti la manifestazione e festa storica più importante e rinomata d'Italia.[3]
La storia del Palio di Siena è però più articolata e complessa, e affonda le proprie radici in un'epoca ancor più remota. Nelle città italiane del XII e XIII secolo era usanza organizzare corse di cavalli, sia come spettacolo pubblico, sia come competizione tra i diversi allevamenti equini posseduti dai nobili cittadini e non. A queste origini si ricongiungono idealmente le diverse rievocazioni storiche che ancora si svolgono in Italia. Ma questo tipo di Palio non è ancora il diretto progenitore della competizione senese attuale.
Parallelamente ai palii dei nobili, i cittadini di Siena cominciarono ad organizzare, più o meno spontaneamente, altre competizioni nei modi più disparati. Si ricordano, a partire dal XV secolo: Palii rionali, l'Elmora, Giorgiani (o Juvenali), Giochi delle pugna, Pallonate, Cacce dei tori, Bufalate, Asinate.
Molte di queste competizioni erano precedute da cortei, rappresentazioni allegoriche, carri trionfali a tema mitologico greco. Notizie di palii si hanno attraverso tutto il XV e il XVI secolo, ma in alcuni casi è difficile capire se le cronache si riferiscano a palii dei nobili (Palio alla lunga) o già a palii alla tonda[4]. L'organizzazione su base rionale della Festa e delle comunità trova la sua origine, probabilmente, nel tipo di organizzazione territoriale delle compagnie militari che caratterizzava l'esercito senese medievale. Quando non c'era la guerra, questa organizzazione si riversava nella competizione nei giochi già citati. Su questa organizzazione interclassista sono state fatte anche interpretazioni di tipo antropologico, relative al carattere territoriale dell'organizzazione sociale senese opposto a quello classista o per censo più diffuso, ad esempio, nei paesi anglosassoni.

La corsa del Palio prende il nome, e non solo a Siena, dal premio: il Palio, dal latino pallium (mantello di lana), era in genere un drappo di stoffa molto pregiata che veniva utilizzato per gli scopi più svariati. A Siena, in genere, era destinato alla chiesa del rione vincitore. Poteva essere utilizzato sia come arredo per la chiesa stessa, o per altri scopi analoghi. Un pallium cinquecentesco sembra abbia decorato fino a non moltissimi anni fa l'altare della Chiesa di San Giuseppe, della Contrada Capitana dell'Onda. Questo avveniva perché, ai loro albori, le Contrade si appoggiavano per le loro riunioni alle Parrocchie o alle compagnie laicali che sostenevano e supportavano gli ordini monastici. È comprensibile come, in caso di vittoria, il premio venisse regalato alla Chiesa del rione, sia per riconoscenza sia per devozione. Un'altra possibilità era la restituzione del premio alla Comunità civica in cambio del suo valore in denaro. In questo caso l'importo poteva essere usato, ad esempio, per fornire di dote le giovani più indigenti della contrada o per altre spese di utilità comune. È dal Settecento che si afferma l’idea del Palio-dipinto (il più antico conservato a Siena, presente nel museo della contrada dell'Aquila, risalente al 2 luglio 1719) e solo dopo la Seconda guerra mondiale che a dipingerlo vengono chiamati non più i bravissimi artigiani senesi (vedi Federico Joni e i falsari senesi di inizio Novecento) ma pittori di fama nazionale e internazionale.
Tra i vari spettacoli e competizioni, nel XVI secolo si va lentamente affermando il Palio alla tonda, quello che conosciamo anche ai giorni nostri. Questo si accentua dopo il 1555, anno in cui termina la guerra di Siena e la città, sconfitta, si richiude in sé stessa sfogando il peso della perdita della libertà nei giochi e nelle celebrazioni al suo interno.
Il vero elemento ‘scatenante’ del Palio moderno sta probabilmente in un episodio avvenuto durante l'occupazione fiorentina e spagnola della città. Verso la fine del Cinquecento una famosa Pietà conservata in un tabernacolo nel rione dove aveva abitato Provenzano Salvani, che si diceva essere stata posta nella sua collocazione da Santa Caterina tre secoli prima, fu oltraggiata da un soldato spagnolo. Forse in preda all'alcool, egli sparò alla statua, rimanendo ucciso dall'esplosione del suo stesso archibugio. Era il 2 luglio e, per commemorare il miracolo fatto dalla Vergine protettrice di Siena contro gli occupanti, i cittadini cominciarono di anno in anno a celebrare con sempre maggiore sfarzo l'anniversario. Tra le varie celebrazioni, fu naturale inserire una corsa del Palio. Nel 1611 fu anche innalzata la Basilica di Provenzano che custodisce quello che resta dell'immagine sacra oltraggiata, la Madonna di Provenzano.
Questa corsa differiva dalle altre organizzate spontaneamente in altre occasioni: vi partecipavano le contrade (quindi il popolo) e non i nobili; si correva in Piazza del Campo alla tonda e non attraverso le strade della città alla lunga (organizzato dalla nobiltà) o in uno specifico rione. Bisogna presupporre che esperimenti di questo tipo di corsa fossero già stati fatti in precedenza, ma è solo all'inizio del Seicento che il Palio moderno si afferma nel gusto ludico dei senesi.
Dal 1656 il Comune di Siena (allora denominato Balìa) si prende in carico l'organizzazione del Palio, consolidando una festa che sappiamo essere precedente. Era nato il Palio di Provenzano come lo conosciamo oggi. I costi del Palio saranno presi in carico dall'aristocrazia fino al 1836.
I verbali della comunità senese relativi all'effettuazione del Palio esistono dal 1659 ed è quindi da questo anno che si conteggiano le vittorie "ufficiali" delle Contrade da parte del Comune. Le registrazioni delle vittorie antecedenti a questo anno sono da considerarsi attendibili solo se suffragate da documenti conservati presso le singole Contrade o da ricerche storiche approfondite.
Nel 1701 si comincia a correre, in maniera intermittente perché ancora spontanea, anche il Palio dell'Assunta. La data del 16 agosto sembra in questo caso ‘anomala’ in quanto successiva al giorno di festa della Madonna Assunta. Venne scelta questa data perché gli altri giorni canonici delle feste d'agosto, il 14 e il 15, a Siena erano già ‘occupati’, rispettivamente, dal Corteo dei Ceri e dei Censi e dalla festa dell'Assunta che culminava nel Palio alla lunga. Quest'ultimo andrà pian piano a perdere di importanza, fino ad essere abolito all'inizio dell'Ottocento, in concomitanza col propagarsi delle idee della Rivoluzione Francese e la conseguente perdita di centralità del ceto nobiliare.
Questo nuovo Palio d'agosto era all'inizio un prolungamento dei festeggiamenti della Contrada vincitrice del Palio di luglio, che lo organizzava a proprie spese (quando economicamente possibile, di qui la sua saltuarietà). Dal 1802 segue la stessa sorte di quello di luglio, cominciando ad essere organizzato dall'ormai costituito Comune di Siena moderno.
Nel 1729, la governatrice di Siena Violante di Baviera stabilisce i confini delle Contrade. A causa di incidenti occorsi negli anni precedenti, decreta inoltre che non possano partecipare più di 10 Contrade alla volta.
Queste sono le date in cui si corre il Palio, la cui caratteristica principale è appunto quella di non costituire una rievocazione storica, in quanto a differenza di altre manifestazioni simili si disputa ininterrottamente[5] da alcune centinaia di anni.[6]
È il Comune di Siena a organizzare il Palio, a gestirne l'aspetto economico (tranne, naturalmente, per quanto riguarda le somme elargite dalle singole contrade ai fantini ingaggiati o per i patti con altre contrade) e quello della giustizia paliesca (eventuali sanzioni a fantini e/o contrade in caso di violazioni del regolamento paliesco): il Palio si autofinanzia dalla comunità senese e non prevede (né accetterebbe) alcun tipo di sponsorizzazione,[7] come si può vedere dalle immagini della Carriera in cui non compaiono mai cartelloni né scritte pubblicitarie.
Il palio è trasmesso ogni anno in Eurovisione, in Italia dalla RAI.
Il Palio è tutto l'anno

Nonostante siano numerose le attività che si svolgono all'interno di ogni Contrada, l'organizzazione del Palio resta la principale, in quanto quest'ultimo non consiste semplicemente in due corse annuali: ogni volta la Festa vera e propria si snoda in quattro giorni intensi, ricchi di vari appuntamenti, la cui preparazione dura tutto l'anno.
Le dirigenze, sin dall'inverno, curano le strategie tenendo i contatti con i fantini e i proprietari di cavalli. Questi ultimi preparano i soggetti che correranno in Piazza sia facendo correr loro altri Palii minori (la cosiddetta provincia) sia portandoli alle corse di addestramento organizzate dal Comune in primavera.
Si entra pienamente nel clima paliesco a fine maggio, con l'estrazione a sorte delle tre contrade che affiancheranno le sette che corrono di diritto: con il quadro delle contrade delineato per intero si può iniziare a parlare davvero di "monte" (ingaggio dei fantini) e di "partiti" (patti segreti per la vittoria), nonostante l'incognita del cavallo che toccherà in sorte.
Circa una settimana prima del Palio viene presentato il Drappellone che il Comune ha commissionato ad un artista locale (nel caso del Palio di luglio) o di fama internazionale (nel caso del Palio di agosto o di uno straordinario). Sempre in queste ore avvengono le visite preliminari dei cavalli che si intende presentare alla tratta.
Nel primo dei quattro giorni di Festa si tiene la tratta, l'estrazione a sorte e successivo abbinamento dei barberi alle contrade in gara. Sull'anello di pietra serena intorno alla Piazza, ricoperto da uno strato di terra composto da una miscela di tufo, argilla e sabbia, si corrono in tutto sei prove, durante le quali i fantini hanno la possibilità di conoscere meglio il comportamento del cavallo che monteranno e di farlo abituare alla Piazza, ai suoi rumori e ai ritmi propri della corsa. Anche le prove vengono seguite da numerosi contradaioli e turisti, sia in Piazza che sui palchi montati all'esterno della pista.
Tra gli appuntamenti che segnano l'avvicinarsi della Carriera vi sono la cena della prova generale, la cosiddetta "Messa del fantino" e la benedizione di cavallo e fantino.
Il Palio straordinario
Il Palio straordinario si tiene nel periodo compreso tra maggio e settembre, ed è legato ad eventi o ricorrenze di particolare rilevanza per la comunità senese. L'ultimo straordinario è coinciso con l'avvento del nuovo millennio: è stato infatti disputato il 9 settembre 2000 ed è stato vinto dalla Selva, grazie al fantino Giuseppe Pes detto Il Pesse sul cavallo Urban II. L'attesa dall'ultimo straordinario è stata di quattordici anni, essendosi disputato il precedente il 13 settembre 1986 per celebrare il II Centenario dell'abolizione della Balìa e della Biccherna. Un'attesa particolarmente lunga rispetto alla media degli ultimi due secoli: nel Novecento si è atteso più di quattordici anni solo dal 1928 al 1945, complice l'interruzione bellica.
Nelle primissime occasioni, il terzo Palio era un modo per onorare illustri ospiti di passaggio od in visita a Siena. Fanno da esempio il Palio straordinario del 7 giugno 1676, corso in occasione della visita a Siena della consorte del Principe Don Agostino Chigi, o anche quello del 15 giugno 1673 (comunque non considerato ufficiale), organizzato in occasione della visita a Siena del cardinale Flavio Chigi. Addirittura bastava la richiesta del Gran Duca di turno per correre un altro Palio, magari a ridosso di quello ordinario.
A partire dalla seconda metà dell'Ottocento iniziarono ad essere indetti Palii straordinari per la celebrazione di particolari avvenimenti, piuttosto che visite illustri: fu il caso di un congresso della Società delle Scienze, o l'inaugurazione di importanti monumenti cittadini (come per l'inaugurazione del monumento ai caduti nella Battaglia di Curtatone e Montanara, il 29 maggio 1893). Sempre nell'Ottocento si sviluppò l'abitudine della formula alla romana: le contrade divise in batterie, le cui vincitrici disputano una finale a tre. Nel 1896 addirittura si corsero quattro Palii: i due ordinari più due straordinari. Il primo si corse il 16 agosto, ma è considerato straordinario perché richiesto dai cittadini in seguito allo spostamento di quello ordinario al 25 agosto a causa del passaggio da Siena del VIII Corpo d'Armata; il secondo il 23 settembre, per l'inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi.
Le novità dei primi del Novecento sono il Palio a sorpresa e quello a sorteggio. Quello a sorteggio nasce dalla proposta di associazioni di cittadini, e bissa il Palio dell'Assunta, abbinando per sorteggio cavalli e fantini alle contrade. Dopo un inizio di secolo con sei straordinari in soli diciassette anni, dal 1928 al 1945 si ha una pausa molto lunga. Il terzo Palio torna appunto nel 1945, a furor di popolo per festeggiare la fine della Seconda guerra mondiale: il cosiddetto "Palio della Pace", vinto da Gioacchino Calabrò detto Rubacuori su Folco, per il Drago.
Negli anni successivi nasce l'abitudine di correre in occasioni di centenari di particolare importanza. È il caso del 28 maggio 1950, per il V Centenario della canonizzazione di San Bernardino da Siena, oppure il 5 giugno 1961 per il I Centenario dell'Unità d'Italia, e così via. Ultimo caso è appunto il Palio straordinario del 2000.
Il 3 dicembre 2008 fu esaminata la proposta di correre un Palio straordinario nel 2009 per il 700º anniversario del Costituto di Siena ma tale decisione fu non accolta dalle 17 Contrade per il difficile momento economico che sta attraversando la città.[8]
La Carriera
La corsa, una delle più antiche al mondo,[9] si svolge nella piazza centrale di Siena, Piazza del Campo[10][11].
Ad ogni Palio partecipano solo dieci Contrade tra le diciassette totali, scelte a sorte e secondo un turno che va di luglio in luglio e di agosto in agosto. Il meccanismo è il seguente:
- corrono di diritto le sette Contrade che non hanno corso il Palio corrispondente dell'anno precedente;
- un mese prima del Palio (l'ultima domenica di maggio per il Palio di luglio e la prima domenica dopo il Palio di luglio per il Palio d'agosto) vengono estratte a sorte tre Contrade che vanno a completare il lotto di dieci;
- le altre sette vengono estratte per stabilire l'ordine di sfilata nel Corteo storico e parteciperanno di diritto al corrispondente Palio dell'anno successivo (mantenendo questo ordine di estrazione);
- in caso di Palio straordinario, avviene un sorteggio tra tutte le contrade per determinare le dieci partecipanti.

Il Palio viene vinto dal cavallo, con o senza fantino, dopo che per primo abbia compiuto tre giri della piazza in senso orario (la 'vulgata' dice "a condizione che questo porti sulla fronte la spennacchiera, cioè la coccarda con i colori della Contrada per la quale sta correndo"; in realtà essa ha solo valore decorativo e di aiuto visuale).[12] La partenza, o mossa, si trova all'altezza del vicolo della Costarella dei Barbieri. La linea d'arrivo, segnalata da un bandierino, è nella stessa zona, pur non coincidendo esattamente con la linea di partenza. Il premio per la Contrada è il palio, o drappellone, o cencio, stendardo rettangolare di seta dipinto a mano.
Nel pomeriggio, prima della corsa, dal Duomo alla piazza si snoda la passeggiata storica durante la quale sfilano sia i mazzieri, i figuranti e i cavalieri rappresentanti il Comune e le istituzioni storiche cittadine sia le comparse delle Contrade i cui figuranti indossando le monture (costumi) con i colori della propria Contrada, la Patria dei senesi.
Dopo il corteo storico (alle 19:30 a luglio, alle 19 ad agosto), i fantini si avvicinano alla mossa uscendo dall'Entrone, l'ingresso del cortile del Palazzo comunale, e si portano nella zona della partenza. A questo punto, il Mossiere, giudice unico della validità della partenza e situato su un palco detto verrocchio, riceve una busta contenente l'ordine di allineamento ai canapi, due lunghe corde che delimitano la zona di partenza. Per accedere alla zona tra i due canapi, la corda posteriore è più corta ed è sorretta da un meccanismo chiamato verrocchino; in questo modo viene lasciato uno spazio attraverso il quale i cavalli fino al nono possono entrare e quello sorteggiato di rincorsa può determinare il momento di partenza (vedi sotto). L'ordine è segreto fino all'ultimo momento e viene determinato con un meccanismo automatico: l'ordine della mossa viene conosciuto solo pochi minuti prima di queste operazioni dai tre Deputati della Festa, i fiduciari del Comune nominati di Palio in Palio, garanti e responsabili del corretto svolgimento della Festa.

La corsa, a quel punto, potrà prendere il via solo quando i primi nove cavalli risulteranno allineati di fronte al canape: solo a quel punto la rincorsa (il fantino che cavalca l'ultimo cavallo estratto) potrà entrare tra i canapi già al galoppo scavalcando con un salto il canape posteriore e dare il via alla corsa. Di conseguenza chi decide il momento di inizio della corsa non è il mossiere ma il fantino del cavallo di rincorsa. Piuttosto, la capacità del mossiere sta nel riuscire a percepire per tempo l'azione della rincorsa e sganciare con un pedale il canape anteriore posto davanti alla linea degli altri nove cavalli con il giusto tempismo, ovvero non troppo presto (svantaggiando il cavallo di ricncorsa) né troppo tardi (svantaggiando i cavalli in linea rispetto a quello di rincorsa); ovviamente la mossa si può ripetere più volte.
Proprio a causa della delicatezza della fase di partenza è comune che strategie, veti incrociati, tentativi di raggiungere accordi rendano le fasi della mossa assolutamente incomprensibili ai profani del Palio tanto che di rado la partenza avviene in pochi minuti. Ogni fantino sa che deve cercare non solo le migliori condizioni per una buona partenza del proprio cavallo ma anche cercare le condizioni sfavorevoli per le contrade rivali. Pertanto una delle preoccupazioni della rincorsa è quella di partire nel momento in cui le contrade rivali sono nelle condizioni peggiori al canape. Inoltre i momenti prima della partenza sono quelli in cui i fantini possono chiedere e cercare collaborazioni o aiuti ad altri fantini; di conseguenza queste operazioni di partenza a volte risultano molto lunghe e si possono protrarre anche fino al calare della sera. Se la mossa si protrae a lungo e la visibilità diminuisce eccessivamente, il Palio può essere rinviato al giorno successivo.
Appena il fantino giunge al traguardo (il bandierino), centinaia di contradaioli festanti si precipitano sotto il palco dei Capitani a ritirare il Palio, che sarà dapprima portato in chiesa, poi conservato per sempre nel museo di Contrada.
Il fantino viene portato in trionfo: la Contrada festeggerà a partire dalla sera stessa e per settimane con una serie di cortei e cenini. In particolare, è usanza festeggiare con tanti cenini quante sono le vittorie conseguite: se per esempio è la 56° vittoria, per 56 sere ci saranno cenini e festeggiamenti. Ancor di più viene festeggiato il cavallo, in special modo nel caso di una vittoria da scosso, cioè senza fantino. L'animale è comunque l'ospite d'onore alla cena della vittoria che si svolge nelle ultime settimane di settembre nelle strade e nelle piazze del rione vincitore del Palio di luglio, la prima settimana di ottobre per il rione vincitore del Palio di agosto.
La vittoria, tra festeggiamenti e ricompense, ha un notevole costo economico per una Contrada, ma chi ha perso non si consola affatto con le cifre ricevute per aver agevolato il vincitore[non chiaro]; arrivare secondi rappresenta invece l'autentica sconfitta. Chi ha vinto festeggia anche la sconfitta della rivale; per chi non ha vinto, vedere perdere la propria rivale rappresenta comunque un successo.[13]
Giustizia paliesca

Secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Palio di Siena, nella giustizia paliesca esistono tre livelli sanzionatori per le Contrade. In ordine di gravità crescente sono comminate: censure, deplorazioni e squalifiche. Una deplorazione scatta dopo aver ricevuto quattro censure; una squalifica scatta dopo tre deplorazioni[14].
La censura rimane valida per i 5 Palii seguenti a quello per cui essa viene comminata; la deplorazione vige invece per 9 Palii. Quando una contrada subisce una squalifica (viene cioè esclusa dal disputare uno o più Palii), essa può scontarla a partire dal Palio a cui dovrebbe partecipare: se cioè viene estratta a sorte, oppure se deve corrervi di diritto. Se la contrada squalificata è estratta per correre, viene automaticamente esclusa e al suo posto è estratta un'altra Contrada. Il periodo massimo di squalifica è di dieci anni.
La giurisdizione è di competenza dell'Amministrazione Comunale. L'iter, regolato dall'art. 98, prevede che l'assessore delegato notifichi alle Contrade la Relazione stilata dai Deputati della Festa, contenente le richieste di squalifica e le motivazioni. Entro il termine massimo di dieci giorni le Contrade hanno la facoltà di presentare memorie difensive; la Giunta Comunale, esaminate le motivazioni dei Deputati della Festa e la difesa delle Contrade, delibera sulle squalifiche entro il 30 novembre di ogni anno, in modo inappellabile. Tutte le punizioni per le Contrade vengono comunicate al Magistrato delle Contrade[14].
Le sanzioni previste per i fantini sono due: l'ammonizione e la squalifica per uno o più Palii, anche a tempo indeterminato. Il procedimento è analogo a quello previsto per le Contrade: dopo la Relazione dei Deputati della Festa, il fantino ha dieci giorni di tempo per presentare proprie memorie difensive. Entro il 30 novembre la Giunta Comunale adotta la propria delibera, contro la quale non è previsto ricorso. Anche le squalifiche ai fantini vengono comunicate al Magistrato delle Contrade[14].
Storia
La prima squalifica a una Contrada nella storia del Palio di Siena è datata 20 agosto 1945: venne comminata alla Tartuca e Bruco, in seguito al Palio straordinario dedicato alla fine della seconda guerra mondiale (detto il "Palio della Pace", nonostante sia uno dei Palii più violenti di sempre[15]). La Tartuca venne squalificata perché decise di ritirarsi dopo due mosse annullate, che l'avevano vista scattare nettamente in testa, il Bruco, in seguito al comportamento dei contradaioli al termine del Palio[16]: i brucaioli infatti strapparono il drappellone dopo la vittoria ai propri danni subita dal Drago. Tuttavia la sanzione, che prevedeva una squalifica per tutto l'anno 1947, venne annullata tra aspre polemiche[15] il 24 aprile 1946[16][17].

Bisogna arrivare all'agosto 1966 per la prima effettiva squalifica a una Contrada: ne subirono le conseguenze il Valdimontone, squalificato per un Palio dopo alcuni incidenti provocati dai contradaioli nel corso della terza prova, e ancora una volta la Torre, squalificata per due Palii perché riconosciuta responsabile di invasione di pista[15]. Non vi furono squalifiche fino al 1973 (un Palio per l'Istrice) ma a partire dal 1979 la frequenza divenne quasi di almeno una sanzione l'anno fino al 2002 (fanno eccezione il trienno 1984-1987 e il 1998, periodi senza alcun provvedimento). La squalifica più pesante mai inflitta a una Contrada è stata comminata all'Istrice dopo il Palio del 16 agosto 2002: la Contrada di Camollia venne sospesa per 4 Palii, scontati poi dall'agosto 2003 al luglio 2005. Il motivo è legato al pestaggio dei contradaioli al termine della corsa, ai danni del fantino della Lupa Giuseppe Pes detto il Pesse, accusato di non aver rispettato alcuni accordi presi in precedenza. Sei degli aggressori vennero anche arrestati[18][19].
Nel 1877 la squalifica toccò ad un fantino: Angelo Romualdi detto Girocche venne sospeso per 2 anni perché, secondo la relazione dell'epoca[20]:
«[...] gettò lo spavento e la costernazione in molti spettatori che lo credevano morto o gravemente ferito, mentre che effettivamente non aveva riportato che alcuna lesione ed era in stato di ubriachezza eccessiva che lo impediva di reggersi in piedi e gli aveva tolto i sensi.»
Nel 1896 Ansano Giovannelli detto Ansanello subì anch'egli 2 anni di squalifica, per non aver corso i tre giri previsti dal Regolamento. Il fantino si rese infatti protagonista di un celebre tradimento ai danni della propria Contrada (la Torre): alla terza curva del Casato si fermò improvvisamente, fece passare la rivale Oca, scese da cavallo e si consegnò ai Carabinieri. Il primo fantino squalificato a vita fu Ermanno Menichetti detto Popo, sospeso nel luglio 1908 per aver tentato di impedire il passaggio alla terza curva di San Martino del fantino dell'Oca. Stessa sorte toccò a Guido Duchi detto Martellino nel 1909 (ostacolò il fantino della Civetta e a Edoardo Furi detto Randellone nel 1928 (prese le redini del cavallo di un'altra Contrada durante la mossa).
Dal dopoguerra sono molti i fantini squalificati, principalmente per irregolarità e disordini creati durante la mossa. La sanzione più pesante è stata inflitta a Franco Casu detto Spirito, e a Maurizio Farnetani detto Bucefallo; i due subirono 20 Palii di squalifica, rispettivamente nell'agosto 1996 e 1997. Il primo, al momento della partenza del Palio, trattenne Massimo Coghe detto Massimino dal giubbetto, impedendogli di fatto di correre; il secondo, ostacolò Luigi Bruschelli detto Trecciolino.
Statistiche
Vincitori delle ultime carriere
- 16 agosto 2012: Valdimontone (Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Lo Specialista)
- 2 luglio 2012: Onda (Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Ivanov)
- 16 agosto 2011: Giraffa (Andrea Mari detto Brio su Fedora Saura)
- 2 luglio 2011: Oca (Giovanni Atzeni detto Tittìa su Mississippi)
Chi corre
- 2 luglio 2013: Valdimontone Pantera Oca Civetta Istrice Lupa Torre Leocorno Onda Nicchio
- 16 agosto 2013: Aquila Bruco Chiocciola Lupa Nicchio Oca Torre e altre 3 contrade da estrarre a sorte il 7 luglio
Vittorie per Contrada[21]
| Contrada | Vittorie totali | XVII secolo | XVIII secolo | XIX secolo | XX secolo | XXI secolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | 24 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 |
| Bruco | 37 | 6 | 7 | 16 | 5 | 3 |
| Chiocciola | 51 | 4 | 19 | 14 | 14 | 0 |
| Civetta | 33 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 |
| Drago | 36 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 |
| Giraffa | 34 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 |
| Istrice | 41 | 4 | 11 | 14 | 10 | 2 |
| Leocorno | 30 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 |
| Lupa | 34 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Nicchio | 42 | 5 | 10 | 12 | 15 | 0 |
| Oca | 64 | 8 | 14 | 20 | 20 | 2 |
| Onda | 38,5 | 3 | 9,5 | 14 | 11 | 1 |
| Pantera | 26 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| Selva | 37 | 2 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| Tartuca | 47,5 | 4 | 11,5 | 16 | 12 | 4 |
| Torre | 44 | 6 | 12 | 20 | 5 | 1 |
| Valdimontone | 44 | 2 | 16 | 10 | 15 | 1 |
| Totali | 663 | 58 | 168 | 211 | 202 | 24 |
Anni di ritardo dall'ultima vittoria
| Contrada | Ultima vittoria | Ritardo |
|---|---|---|
| Lupa (nonna) | 2 luglio 1989 | 34 anni e 355 giorni |
| Aquila | 3 luglio 1992 | 31 anni e 354 giorni |
| Nicchio | 16 agosto 1998 | 25 anni e 310 giorni |
| Chiocciola | 16 agosto 1999 | 24 anni e 310 giorni |
| Drago | 16 agosto 2001 | 22 anni e 310 giorni |
| Torre | 16 agosto 2005 | 18 anni e 310 giorni |
| Pantera | 2 luglio 2006 | 17 anni e 355 giorni |
| Leocorno | 16 agosto 2007 | 16 anni e 310 giorni |
| Istrice | 2 luglio 2008 | 15 anni e 355 giorni |
| Bruco | 16 agosto 2008 | 15 anni e 310 giorni |
| Civetta | 16 agosto 2009 | 14 anni e 310 giorni |
| Selva | 2 luglio 2010 | 13 anni e 355 giorni |
| Tartuca | 16 agosto 2010 | 13 anni e 310 giorni |
| Oca | 2 luglio 2011 | 12 anni e 355 giorni |
| Giraffa | 16 agosto 2011 | 12 anni e 310 giorni |
| Onda | 2 luglio 2012 | 11 anni e 355 giorni |
| Valdimontone | 16 agosto 2012 | 11 anni e 310 giorni |
Polemiche e misure per la sicurezza equina

Da diversi anni, il Palio è oggetto di alcune proteste da parte delle associazioni animaliste, tra cui la Lega Anti Vivisezione. Tali proteste riguardano soprattutto gli incidenti di gara che provocano rovinose cadute e che, in alcuni casi, hanno portato alla morte del cavallo.
I calcoli sulla percentuale di incidenti causati dal Palio variano a seconda di chi li effettua. I dati che fornisce la Lega Anti Vivisezione dicono che dal 1970 al 2007 sono morti complessivamente 48 cavalli[22], pari al 50% di incidenti mortali per edizione, considerando sia quelli feriti durante la gara e abbattuti successivamente lontano dalle telecamere, sia quelli morti durante gli interventi. Per contro, i calcoli eseguiti dai sostenitori del Palio danno una percentuale del 2,05%[23] di incidenti mortali per corsa, in quanto, tra batterie di selezione, prove e palio, se ne svolgono non meno di una decina per edizione; si rileva, tra gli errori contenuti nel dossier della LAV, l'inclusione di soggetti mai esistiti o che non hanno mai preso parte ad alcuna corsa a Siena.
Un altro dato da considerare è che molte norme che regolano la salvaguardia degli animali sono state sviluppate e attuate soltanto a partire dagli anni novanta: i dati, sia degli animalisti sia dei sostenitori del palio, sottolineano come la casistica si sia drasticamente ridotta dopo questa data.
Negli ultimi decenni il Comune di Siena ha adottato una serie di misure per garantire la salvaguardia dei cavalli (e dei fantini) prima, durante e dopo la corsa. Tra i provvedimenti presi vi sono:
- una previsita sanitaria obbligatoria, tenuta da una commissione nominata dalla Giunta comunale e formata da due veterinari (tra cui quello comunale);[24]
- analisi ematochimiche, introdotte nel maggio del 1999, al fine di ribadire e verificare quanto da sempre previsto dal Regolamento, ovvero il divieto di somministrazione di sostanze ad attività stimolanti e depressanti ed anestetici locali;[25]
- approvazione nel 1999 del "Protocollo per l'erogazione di incentivi per il mantenimento dei cavalli da Palio" ed istituzione dell'Albo dei cavalli continuamente e appositamente addestrati per correre sul Campo. Nel 2004 sono stati introdotti invece un Albo degli allevatori dei cavalli mezzo sangue a fondo arabo (ritenuti fisicamente più adatti alla corsa) ed un Albo delle fattrici;[26]
- costruzione di una pista in località Mociano, identica per forma e pendenza a Piazza del Campo. Da marzo a giugno si tengono qui, oltre che a Monticiano e a Monteroni d'Arbia, i lavori e le corse di addestramento obbligatori per i cavalli che s'intende portare al Palio;[27]
- protezioni (un tempo note come materassoni) presenti alla curva di San Martino, dal giugno del 1999 allestita con una barriera di protezione ad alto assorbimento in PVC, innalzamento del parapetto alla Curva del Casato e introduzione di camicie di sicurezza per il pronto intervento del personale del 118;[28]
- intervento sulla composizione, metodologia di applicazione e monitoraggio dello strato di tufo;[28]
- mantenimento dei cavalli non più in condizioni di correre il Palio (per l'età avanzata o per infortunio) presso il Centro ippico del Corpo Forestale dello Stato "Il Caggio" del comune di Radicondoli;[29]
- alcol-test ai fantini[30] come da ordinanza del sottosegretario alla Salute Francesca Martini[31].
Tali misure vengono giudicate comunque insufficienti da alcune associazioni animaliste, che continuano a chiedere l'abolizione della gara. Proprio al riguardo, uno studio del 2010 condotto dall'Università di Parma[32] finalizzato alla comparazione delle patologie traumatiche dei cavalli da ippodromo e da corse storiche degli ultimi venti anni, ha permesso di verificare che non esiste differenza in termini percentuali tra incidenti nelle corse regolari e nelle corse storiche[33]. In particolar modo, un'analisi approfondita degli ultimi quarant'anni del Palio di Siena ha permesso di scoprire che vi è stata una riduzione percentuale di incidenti catastrofici: dal 2,20% di incidenti nel decennio 1970-79 allo 0,53% del decennio 2000-09[34].
Terminologia
Nel Palio è in uso da tempo immemorabile una terminologia specifica per definire i diversi protagonisti o momenti della corsa. Di seguito, alcuni termini più noti:
- Alfiere: lo sbandieratore di una Contrada;
- Bandierino: il punto d'arrivo della carriera;
- Barbaresco: il contradaiolo addetto alla cura del cavallo;
- Barbero: il cavallo da corsa, ma anche le tradizionali biglie di legno colorate con le insegne delle Contrade, caratteristico gioco senese;
- Bombolone: cavallo molto forte;
- Brenna: cavallo considerato scarso;
- Canapi: le grosse funi che delimitano la zona della mossa, ma anche il periodo di attesa della partenza della corsa, proverbialmente piuttosto lungo e carico di tensione (stare "fra i canapi");
- Capitano: il contradaiolo che, durante il periodo del Palio, è plenipotenziario della gestione della contrada;
- Cappotto: quando una contrada riesce a vincere, nello stesso anno, entrambi i Palii (l'ultimo nel 1997 da parte della Giraffa);
- Carriera: la corsa;
- Carroccio: il carro tirato da buoi che durante il corteo storico trasporta il palio;
- Cencio: il palio (il drappo che viene assegnato al vincitore);
- Comparse: i rappresentanti in costume di una Contrada che partecipano al corteo storico;
- Contrade soppresse: nel XVII secolo queste andarono lentamente estinguendosi per carenze organizzative, non partecipazioni alla vita pubblica e così via. Il loro territorio fu inglobato dalle Contrade confinanti e di loro rimane traccia negli stemmi di alcune Contrade attuali. Le ultime contrade soppresse furono: Gallo, Orso, Vipera, Quercia, Leone, Spadaforte[35].
- Cuffia: il simbolo metaforico della Contrada nonna, quella cioè che ha la sua ultima vittoria più lontana nel tempo;
- Drappellone: il palio (drappo che viene assegnato al vincitore);
- Duce: figura rievocata nel corteo storico, rappresenta il comandante delle compagnie militari delle antiche contrade medievali. Nel Palio moderno è solo una figura rappresentativa, senza alcun potere;
- Mangino: è il nome comunemente usato a Siena per la carica di Tenente della Contrada, il braccio destro del Capitano di Contrada, che, assieme a questo organizza i partiti per la Contrada durante il Palio; ogni contrada ha due Tenenti (Mangini)
- Masgalano (l'etimologia della parola proviene dallo spagnolo: "mas galante", cioè "più elegante"): oggetto scolpito (originariamente un piatto, in tempi più recenti prende via via varie forme e dimensioni) solitamente in metallo prezioso che viene assegnato alla Contrada che abbia effettuato la migliore figura nel corteo storico. In pratica consiste in un premio ai figuranti, in special modo gli alfieri ed il tamburino, più abili;
- Montura: indica gli abiti, ispirati all'epoca rinascimentale, utilizzati dalle comparse (o monturati) delle diverse Contrade durante il corteo storico che precede la corsa;
- Mossa: indica l'inizio della corsa vera e propria, ma anche il punto della piazza da dove la corsa parte;
- Mossiere: il personaggio designato a regolamentare la partenza (mossa) della corsa;
- Nerbata: l'utilizzo del nerbo contro un fantino avversario;
- Nerbo: il tendine essiccato di bue utilizzato dai fantini quale frusta;
- Nonna: la Contrada che non vince il palio da più tempo;
- Palio: il termine può essere utilizzato per indicare la corsa dei cavalli, ma anche il drappo assegnato al vincitore della corsa;
- Partiti: gli accordi, più o meno segreti, fra le diverse Contrade per la vittoria del Palio;
- Passeggiata: il corteo storico;
- Priore: in quasi tutte le Contrade, con questo titolo è designato il contradaiolo eletto a capo della Contrada per tutto l'anno (periodo del Palio escluso). Nel Bruco si chiama Rettore mentre nell'Oca è detto Governatore;
- Rincorsa: la posizione di partenza del decimo cavallo, situato al di fuori dello spazio delimitato dai canapi. Poiché è proprio l'entrata del decimo cavallo nei canapi a determinare la partenza della corsa, questa posizione è considerata particolarmente favorevole per favorire (o sfavorire) un'altra Contrada, piuttosto che per la vittoria. Infatti la Contrada di rincorsa parte da una posizione arretrata e deve percorrere una parte del primo giro sul lato più esterno della pista, il che la mette potenzialmente in svantaggio rispetto alle nove che partono dai canapi;
- Scosso: cavallo senza fantino;
- Soprallasso: il cavallo, di scarso valore, che il fantino monta durante il corteo storico;
- Spennacchiera: la coccarda coi colori della Contrada di appartenenza, applicata sulla fronte del cavallo;
- Steccato: le barriere di legno che delimitano internamente la pista. La posizione di partenza "allo steccato" indica le posizioni più interne, considerate comunemente fra le più favorevoli per la vittoria della corsa;
- Tratta: la scelta e l'assegnazione alle Contrade (per estrazione) dei cavalli per la corsa; ha luogo il 29 giugno per il Palio di Provenzano e il 13 agosto per quello dell'Assunta;
- Verrocchio: palco situato appena sopra la zona della mossa, da dove il mossiere gestisce le operazioni relative alla partenza.
Galleria fotografica
-
La folla riempie Piazza del Campo pochi istanti prima della partenza.
-
I cavalli escono dall'Entrone. Un vigile urbano porge ai fantini i nerbi.
-
Operai del Comune tendono i canapi: manca poco all'inizio.
-
Il mossiere dalla sua postazione invita le Contrade ad allinearsi.
-
Entra la rincorsa, la mossa è valida: si parte.
-
Jonatan Bartoletti bacia Brento in segno di ringraziamento, prima di entrare in Chiesa per il Maria Mater Gratiae.
-
Tensione prima del palio del 2 luglio 2011
Filmografia
Il Palio è il soggetto di diversi lungometraggi quali:
- Palio di Alessandro Blasetti (1932)
- La ragazza del Palio di Luigi Zampa (1957)
- Bianco rosso celeste - cronaca dei giorni del Palio di Siena di Luciano Emmer (1963)
- Il bianco e il nero - Tutti i colori del Palio di Siena, di Anton Giulio Onofri (2002)
- The Last Victory di John Appel (2004)
- Visioni di Palio di Anton Giulio Onofri (2004)
Note
- ^ La contrada del Valdimontone, nonostante i suoi colori siano giallo, rosso e bianco, ha l'abitudine di correre il palio col giubbetto del fantino di colore giallo e rosa. Questa usanza, riportata fin dal XVIII secolo, fu formalizzata nel 1833, al fine di evitare confusione con la contrada della Chiocciola, i cui colori (giallo, rosso e blu) sono quasi identici.
- ^ Perciò, quale che sia il significato del Palio, esso ci fornisce una rappresentazione della storia militare, politica e religiosa di Siena al suo apice, cioè della Siena dal 1260 al 1555, da Montaperti alla caduta della Repubblica. da Alan Dundes, Alessandro Falassi, La terra in Piazza. Antropologia del Palio, trad. italiana. Siena, Nuova Immagine Editrice, 2005, pag.20.
- ^ [...] il Palio, infatti, è una miniera inesauribile di simboli, metafore, e modelli relazionali sociologicamente rilevanti. Dundes-Falassi, cit., pag.8.
- ^ Il Palio "alla tonda" è il Palio attuale, corso nell'anello di Piazza del Campo.
- ^ Le uniche eccezioni per i palii regolari sono state: luglio 1798 (per il terremoto a maggio), 1799 (per i moti rivoluzionari), 1800 (proibiti dai francesi, che occupavano la città), agosto 1855 (colera), agosto 1900 (lutto per la morte di Umberto I), nonché il periodo delle 2 guerre mondiali (1915-18 e 1940-44). Cfr. Dundes-Falassi, cit., pag.21.
- ^ Nel 1935 Benito Mussolini decretò che il termine "Palio" dovesse riservarsi esclusivamente a quello di Siena (Dundes-Falassi, cit., pag.17).
- ^ cfr. il Regolamento del Palio (Cap. I, Disposizioni fondamentali) all'art.8: In considerazione delle finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato di promuovere pubblici concorsi, lotterie, od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.
- ^ Il Palio di Siena - News - Straordinario, “Decisione sobria e responsabile”
- ^ La prima allusione al Palio come tradizione consolidata si ha in documenti del 1238 anche se pare si corresse un Palio di San Bonifacio prima del XII secolo, cfr. Dundes-Falassi (cit.), pag.15 e 17.
- ^ Risale al 1583 la prima Carriera con cavalli corsa qui, come riportano Dundes e Falassi (cit., pag.19).
- ^ Durante lo svolgimento del palio arriva a contenere fino a 70.000 spettatori
- ^ Non è infatti menzionata nel Regolamento del Palio come condizione per la vittoria, cfr. Cap. 5 (- Delle corse di prova e dei fantini) all'art. 70: La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuti tre giri della pista, giunga, anche scavezzato, per primo al bandierino di traguardo posto dinanzi al Palco dei Giudici, e ciò ancorché il Fantino, durante la corsa, fosse caduto.
- ^ Queste sono alcune tra le particolarità più evidenti del Palio, cfr. prefazione de La terra in Piazza (cit).
- ^ a b c Regolamento del Palio di Siena - Cap. 8 (Penalità e disposizioni finali), su ilpalio.siena.it. URL consultato il 13 giugno 2012.
- ^ a b c Daccelo! Cronache, personaggi e numeri di un secolo di Palio, Computer Copy, 2000. Errore nelle note: Tag
<ref>non valido; il nome "daccelo1946" è stato definito più volte con contenuti diversi - ^ a b Sergio Profeti, Sunto. I Quaderni - Il libro nero (PDF), Siena, 1980.
- ^ Le squalifiche delle Contrade, su ilpalio.siena.it. URL consultato il 13 giugno 2012.
- ^ Siena, botte a un fantino. Arrestati 6 contradaioli, in la Repubblica, 27 agosto 2002. URL consultato il 15 giugno 2012.
- ^ Daniele Magrini, Palio un anno, 2002: i fatti e le emozioni da ricordare, Master Graphics, 2002.
- ^ Luca Luchini, Palio XX secolo: una città fra realtà e leggenda, Tip. Senese Ed., 1985.
- ^ Orlando Papei, Le vittorie delle singole Contrade, su ilpalio.org. URL consultato il 23-8-2010.
- ^ Il palio di Siena dossier della Lega Anti Vivisezione
- ^ Sergio Profeti, Le vere cifre degli infortuni sul tufo, Ed.Sunto, 2004
- ^ cfr. il Regolamento del Palio (Cap. IV - Della presentazione, scelta ed assegnazione a sorte dei cavalli) all'art.37: I cavalli per poter essere presentati, debbono essere stati sottoposti nei giorni immediatamente precedenti la tratta, su richiesta scritta dei proprietari, a visita da parte di una Commissione Veterinaria, che deve esprimere parere sull'idoneità sanitaria alle corse nel "Campo".
- ^ cfr. il Regolamento del Palio (Cap.V, Delle corse di prova e dei fantini) all'art.57: È dei pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo, sostanze eccitanti, praticare frizioni di ogni genere, od applicar "perette".
- ^ Questo progetto è teso ad ottenere: l'accreditamento dei proprietari, previa verifica di adeguati requisiti; la selezione dei cavalli con caratteristiche rispondenti ai parametrici biometrici considerati ottimali per l'impegno da affrontare; l'allenamento dei soggetti in gare e corse di addestramento al fine di ottimizzare la preparazione e l'adattabilità al percorso del Palio; l'implementazione di un sistema di incentivazione economica per indirizzare i proprietari verso l'acquisto e l'allevamento di cavalli con caratteristiche condivise; il costante monitoraggio degli animali da parte dei veterinari facenti parte dell'apposita Commissione Tecnica Comunale. Cfr. anche Rendiconto Giunta Cenni 2001-2006, pag.275
- ^ cfr. Rendiconto Giunta Cenni, cit.
- ^ a b cfr. Rendiconto Giunta Cenni, cit.
- ^ Vedi Campioni al pascolo, di Gianni Perotti - Famiglia Cristiana n.33 del 14/08/2005 o questo reportage su un sito paliesco amatoriale.
- ^ Palio di Siena, alcol-test per i fantini - Style.it
- ^ ORDINANZA del 21 luglio 2009
- ^ Zanichelli Stefano, Botti Benedetta, Lipreri Giulia, Le patologie traumatiche del cavallo-atleta: corse regolari e Palii a confronto (PDF), aprile 2010, pp. 1-13.
- ^ Come indicato nello studio, per "corse regolari" si intendono le manifestazioni organizzate da associazioni riconosciute quali ad esempio: UNIRE, FISE, FEI. Per "corse storiche" si intendono quelle che restano al di fuori di tali circuiti.
- ^ Le patologie traumatiche del cavallo-atleta: corse regolari e Palii a confronto (PDF), su sunto.biz, Università di Parma. URL consultato il 14-10-2010.
- ^ La leggenda secondo la quale queste fossero state sciolte per legge a causa dei disordini causati in un Palio del 1675 è priva di fondamento documentale: Scheda sulle Contrade soppresse da ilpalio.org, su ilpalio.org. URL consultato il 05-07-2009.
Bibliografia
- AAVV. Visioni di Palio. Siena, Protagon Editori Toscani-Edizioni Alsaba, 2004. ISBN 978-88-8024-130-0
- AAVV. Immagine del Palio. Firenze, Editore Nardini, 2003. ISBN 978-88-404-1171-2
- Luca Betti, Alessandro Falassi. Il Palio - La festa della città. Siena, Betti Editrice, 2003. ISBN 978-88-86417-99-0
- Mauro Civai, Enrico Toti. Palio, la corsa dell'anima. Siena, Edizioni Alsaba, 1995. ISBN 978-88-85331-23-5
- Piero Colle, Aceto. Fino all'ultimo Palio. Firenze, Giunti Editrice, 1996. ISBN 978-88-09-20934-3
- Wolfgang Drechsler. The Contrade, the Palio and the Ben Comune: Lessons from Siena". Trames 10(2), 2006, 99-125.
- Alan Dundes, Alessandro Falassi. La terra in Piazza: an interpretation of the Palio of Siena. Berkeley, University of California Press, 1975.
- Alan Dundes, Alessandro Falassi, foto di Gigi Lusini. La terra in Piazza. Antropologia del Palio, trad. italiana. Siena, Nuova Immagine Editrice, 2005. ISBN 978-88-7145-019-3
- Alessandro Falassi, Per forza e per amore. Milano, Bompiani, 1980.
- Roberto Filiani, Natale Zaffaroni. Con la Rivale in Campo 2, 1960-1989: le rivalità di contrada nelle carriere, nei numeri unici, nei racconti dei personaggi e le squalifiche negli atti dell'autorità comunale. Monteriggioni, Il Leccio, 2003. ISBN 978-88-86507-87-5
- Roberto Filiani, Natale Zaffaroni. Con la Rivale in Campo, 1990-1999: le rivalità di contrada nelle carriere, nei numeri unici, nei racconti dei personaggi e le squalifiche negli atti dell'autorità comunale. Monteriggioni, Il Leccio, 2002. ISBN 88-86507-78-X
- Roberto Filiani, "Daccelo!" - Cronache, personaggi e numeri di un secolo di palio, Siena, Computer Copy, 2000.ISBN non esistente
- Carlo Fruttero, Franco Lucentini. Il Palio delle contrade morte. Milano, Mondadori, 1985. ISBN 978-88-04-27375-2
- Virgilio Grassi. Le Contrade di Siena e le loro feste - Il Palio attuale (vol. II: Il Palio sotto il Regno d'Italia 1859-1937: dal 1859 al 1900, dal 1901 al 1935, anni 1936-1937, più Cronistoria del Palio dal 1938 al 1972, di Alberto Tailetti). Siena, Edizioni U.Periccioli, 1972.
- William Heywood, Nostra donna d'agosto e il Palio di Siena. Siena, Protagon Editori Toscani, 1993. ISBN 978-88-8024-002-0
- Aldous Huxley, The Palio at Siena, Cornhill Magazine, 58 (1925), pp.573-580, trad. it. G. Cillario, Il Palio di Siena, Roma, Messaggerie, 1990.
- Senio Sensi, Armando Santini. Guida al Palio, Siena, Betti Editrice, 1995-2002. ISBN 978-88-86417-16-7
- Sydel Silverman. On the Use of History in Anthropology: The Palio of Siena. American Ethnologist 6(3) (413-436), 1979.
- Per una bibliografia più completa (più di 150 titoli) vedi queste schede.
- La Corsa è inoltre al centro di tre storie a fumetti della Disney: Messer Papero e la Grotta di Eolo e Ser Paperone e Lorenzo il Magnifico, di Guido Martina e Giovan Battista Carpi, e Topolino al Palio di Siena.
Voci correlate
Altri progetti
 Wikiquote contiene citazioni sul palio di Siena
Wikiquote contiene citazioni sul palio di Siena Wikinotizie contiene notizie di attualità sul palio di Siena
Wikinotizie contiene notizie di attualità sul palio di Siena Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul palio di Siena
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul palio di Siena