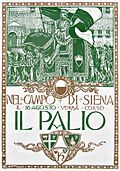Chiesa di Santa Maria di Provenzano
| Chiesa di Santa Maria di Provenzano | |
|---|---|
 | |
| Stato | |
| Regione | Toscana |
| Località | Siena |
| Coordinate | 43°19′15.53″N 11°19′57.5″E{{#coordinates:}}: non è possibile avere più di un tag principale per pagina |
| Religione | Cristiana cattolica di rito romano |
| Titolare | Visitazione |
| Diocesi | Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino |
| Consacrazione | 16 ottobre 1611 |
| Architetto | Flaminio del Turco |
| Stile architettonico | Manierista |
| Inizio costruzione | 1595 |
| Completamento | 1611 |
| Sito web | www.collegiataprovenzano.siena.it |


L'Insigne collegiata di Santa Maria in Provenzano o chiesa di Provenzano si trova a Siena, in piazza Provenzano Salvani. È intitolata alla Visitazione della Beata Vergine Maria a santa Elisabetta ed è il santuario nel quale si conserva l'immagine della Madonna di Provenzano.
Storia
In stile manierista, è uno dei primi edifici costruiti a Siena dopo la conquista medicea della città[1].
Sorge nel territorio attualmente all'interno della Imperiale Contrada della Giraffa, nella piazza intitolata a Provenzano Salvani: politico ghibellino citato spesso da Dante Alighieri e vincitore della battaglia di Montaperti nel 1260. In questa zona un tempo erano presenti proprio le sue case.
La leggenda che si è tramandata narra che sul muro esterno di una delle case del rione era collocata un'immagine in terracotta smaltata raffigurante il tema della Pietà, lì collocata secondo il racconto popolare da santa Caterina da Siena[2].
Nel 1552 accadde che un archibugiere spagnolo, forse per una bravata, tentò di sparare contro l'immagine sacra, ma il suo archibugio scoppiò e finì per uccidere il soldato stesso, lasciando integro il busto della Madonna, distruggendone però le braccia[2][3]. La scultura divenne subito un simbolo: fu venerata, ed alla Madonna vennero attribuiti diversi miracoli, soprattutto nel luglio del 1594[2][3] (in ricordo di tali eventi si corre, dal 1656, il Palio di Provenzano). Si decise pertanto di costruire un santurario, all'interno del quale custodire la sacra immagine: i lavori di costruzione iniziarono il 24 ottobre 1595, quando vennero murate le fondazioni[4]).
Ferdinando I de' Medici affidò i lavori a Damiano Schifardini, senese, monaco alla Certosa di Firenze che coordinò inizialmente i lavori, realizzando il disegno[5][6]. Ma, vista anche la lontananza di Schifardini, fu l'architetto Flaminio del Turco ad occuparsi immediatamente dei lavori, assistito anche da don Giovanni de' Medici per la realizzazione della cupola[5]. I lavori terminarono nel 1604. La chiesa fu dedicata il 16 ottobre 1611. Il 23 ottobre successivo, con una solenne processione che attraversò tutte le vie di Siena, venne traslata all'interno del santuario la sacra immagine[2].
Nel 1614, con decreto granducale, viene istituita l'Opera di Santa Maria in Provenzano, presieduta da un Rettore laico, con il compito di amministrare i beni del santuario e provvedere alle necessità di culto.
La grande devozione alla Madonna di Provenzano fece del santuario il vero e proprio cuore della fede cittadina. Nel 1634 Papa Urbano VIII concede al santuario il titolo di "Insigne Collegiata", officiata da un Capitolo di Canonici, presieduto da un Proposto, che fosse secondo in dignità solo al Capitolo Metropolitano della Cattedrale. Nel 1656 viene deciso di correre ogni anno un Palio in onore della Madonna di Provenzano il giorno 2 luglio, nell'antico calendario liturgico festa della Visitazione, titolare della Collegiata.
Descrizione
Architettura
L'edificio ha pianta a croce latina, unica navata con cupola ottagonale con tamburo all'incrocio del transetto, e facciata in marmo tripartita da lesene, divisa in due piani da un cornicione molto sporgente e culminante in un timpano centrale e due volute laterali. Al centro, il portale è sormontato da un timpano arcuato e da una finestra rettangolare, mentre ai lati si aprono quattro nicchie con le statue dei santi Ansano, Vittore, Caterina e Bernardino. L'impianto architettonico risponde in tutto ai criteri del barocco romano immediatamente successivo al Concilio di Trento, che aveva dettato precise norme in merito alla costruzione delle chiese e alla disposizione degli arredi sacri.
Opere d'arte
All'interno sono conservate numerose opere d'arte. Tre dei quattro altari laterali conservano dipinti di notevole valore: il primo di destra è la Messa di san Cerbone di Rutilio Manetti, che riporta un episodio celebre della vita del santo vescovo patrono della chiesa di Populonia (oggi Massa Marittima). Il vescovo Cerbone era stato accusato di celebrare la Messa troppo presto al mattino, e per questo motivo era stato convocato a Roma da papa Vigilio; il Pontefice volle assistere alla messa celebrata dal santo e poté contemplare i cori angelici che apparvero al momento della consacrazione del pane e del vino, tanto da scagionare Cerbone da ogni accusa. L'altare e la tela furono commissionati dal vescovo di Massa Marittima Fabio Piccolomini poco oltre il 1630. Nel primo altare a sinistra si contempla invece la Visione di santa Caterina del martirio di san Lorenzo di Dionisio Montorselli (1653-1712 circa), collocato in Provenzano nel 1685 e proveniente dalla demolita chiesa di San Lorenzo. L'altare fu commissionato da Ippolito Borghesi, vescovo di Montalcino. Il secondo altare laterale di destra, sul fondo del transetto, conserva una tela raffigurante Santa Caterina da Siena e santa Caterina d'Alessandria di Francesco Rustici, con al centro l'Annunciazione di Giandomenico Manenti. L'altare era di pertinenza della famiglia Venturi. Il secondo altare di sinistra (altare Petrucci) conserva un monumentale crocifisso ligneo del XIX secolo, accompagnato dalle statue dei tre dolenti. Un'altra Crocifissione coi dolenti, seicentesca e di buona fattura, si trova invece all'altare del transetto sinistro.
I pennacchi della cupola furono affrescati a partire dagli inizi del Settecento e raffigurano i quattro santi Patroni di Siena: Ansano, Savino, Crescenzio e Vittore. Fra gli artisti che hanno provveduto a realizzare gli affreschi spicca Giuseppe Nicola Nasini, che nel 1715 realizzò il pennacchio di Sant'Ansano. Interessanti anche lungo le pareti le tele monocrome raffiguranti il Sogno di san Giovanni Evangelista e la Messa di san Gregorio Magno, opere seicentesche di Bernardino Mei e Deifebo Burbarini. Sempre lungo le pareti della navata centrale si possono ammirare quattro grandi tele ottocentesche opera dei pittori puristi Luigi Boschi e Giovanni Bruni, raffiguranti episodi della vita della Vergine: la Natività di Maria, la Visitazione, la Presentazione di Gesù al Tempio e l'Incoronazione.
Degna di nota è la decorazione in marmi policromi del pavimento sotto la cupola, raffigurante al centro i blasoni dei Granduchi di Toscana Cosimo III de' Medici e Margherita Luisa d'Orléans, affiancati dagli stemmi dello Stato senese e dello Stato fiorentino e circondati in senso orario da quelli delle città sedi vescovili presenti nel territorio dell'antica Repubblica di Siena: Grosseto, Sovana, Pienza, Montalcino, Massa Marittima e Chiusi.
L'altare maggiore è opera di Flaminio del Turco, ed è stato realizzato nell'arco di ventiquattro anni, tra il 1617 ed il 1631[1]. Esso ospita il busto quattrocentesco in terracotta della Madonna di Provenzano (già facente parte di un gruppo della Pietà), circondato da una Gloria di Giovan Battista Querci. Sopra all'altare maggiore, nell'abside alta, è esposto un preziosissimo drappo di velluto rosso, ricamato a filo oro, riportante le insegne di papa Alessandro VII, morto nel 1667 e ultimo dei papi senesi. Nella sagrestia, ornata di un complesso ligneo seicentesco, è il Compianto sul Cristo morto di Alessandro Casolani, una Madonna ad affresco di scuola senese del trecento e un dipinto cinquecentesco con la Dedicazione della chisa di Provenzano, interessante testimonianza topografica della città di allora.
All'interno della navata sono esposte due bandiere: quella in abside in alto a sinistra venne presa ai Turchi dal cavaliere senese Paolo Amerighi durante la battaglia di Vienna del 1683, quella nella controfacciata, in alto a sinistra dell'ingresso, che riporta lo stemma dei Medici al centro, era il vessillo militare delle truppe granducali issato sulla Fortezza medicea, portato come segno di devozione alla Madonna dopo la smilitarizzazione della città al tempo del granduca Pietro Leopoldo. Ai pilastri della cupola si trovano altre quattro bandiere, tre prese ai Turchi tra XVII e XVIII secolo, e una ai Boxers cinesi nel 1902.
Palio di Siena
Secondo quanto stabilisce il Regolamento del Palio di Siena, «Il Drappellone è solennemente trasportato, per il Palio del 2 luglio nella chiesa di Santa Maria in Provenzano dopo la prova generale [...] e vi rimane esposto fino a quando deve venire issato sul Carroccio, per il Corteo Storico»[7].
Dopo aver vinto il Palio del 2 luglio, i contradaioli vittoriosi si recano presso la chiesa, portando il Drappellone in segno di ringraziamento alla Madonna di Provenzano.
Note
- ^ a b 2000, Toscana: Firenze, Arno e città d'arte, a cura di Touring club italiano, Touring Editore, a pag. 230., ISBN 88-365-1865-6.
- ^ a b c d Basilica di Provenzano, su comune.siena.it, Comune di Siena. URL consultato il 26-04-2010.
- ^ a b Tratto dal sito portasantandrea.com, su portasantandrea.com. URL consultato il 26-04-2010.
- ^ Progetto di illuminazione della cripta della Basilica di Provenzano, su cinienils.com. URL consultato il 26-04-2010.
- ^ a b (PDF) Recensione della monografia La collegiata di Santa Maria in Provenzano (PDF), su accademiaintronati.it, Accademia degli Intronati. URL consultato il 26-04-2010.
- ^ 1997, Toscana (esclusa Firenze). Volume 11 di Guida d'Italia, a cura di Touring club italiano, Touring Editore, a pag. 574., ISBN 88-365-0948-7.
- ^ Regolamento del Palio di Siena consultabile sul sito ufficiale
Bibliografia
- Toscana. Guida d'Italia (Guida rossa), Touring Club Italiano, Milano 2003. ISBN 88-365-2767-1
Altri progetti
 Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su chiesa di Santa Maria di Provenzano
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su chiesa di Santa Maria di Provenzano